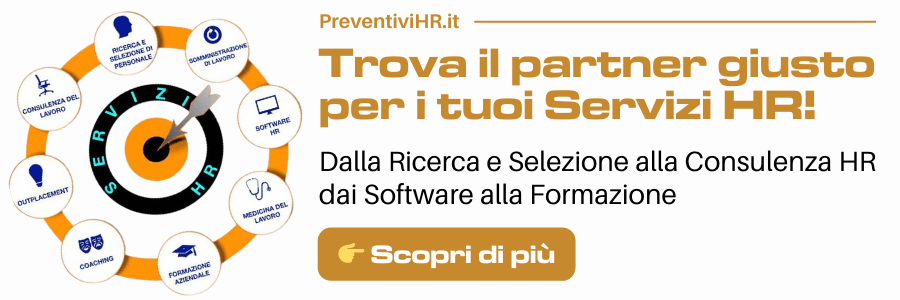ADV
Purpose aziendale: radici sociologiche e applicazioni contemporanee
di RisorseUmane-HR.it
Il purpose aziendale è un elemento fondamentale per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni moderne. Il concetto non è un fenomeno recente né una semplice moda manageriale, ma affonda le sue radici in una lunga tradizione sociologica.
Tra i primi studiosi ad introdurre e sviluppare approfonditamente questo concetto troviamo Philip Selznick, sociologo americano celebre per aver evidenziato come le organizzazioni siano entità vive che perseguono scopi ben precisi, non riducibili unicamente al profitto economico.
In questo approfondimento, analizziamo le origini sociologiche del purpose aziendale e la sua evoluzione fino alle applicazioni più attuali, offrendo spunti teorici e pratici per comprendere e sviluppare uno scopo autentico e strategico all’interno delle organizzazioni.
|
In questo articolo : |
Le radici del Purpose aziendale
Philip Selznick è considerato il padre del concetto moderno di purpose aziendale. Egli sosteneva che le organizzazioni possiedono una dimensione istituzionale che va oltre le logiche tecniche e amministrative. In particolare, affermava che il purpose rappresenta l’identità più profonda di un’organizzazione, definendo la sua ragion d’essere, il significato sociale e il ruolo nell’ambiente in cui opera.
Negli anni successivi, diversi altri sociologi hanno arricchito questo concetto, ciascuno secondo le proprie prospettive teoriche:
- Herbert Simon e James March hanno sottolineato l’importanza della razionalità limitata e dell’identità organizzativa, che influenza in modo determinante il purpose aziendale. Questo approccio evidenzia come le decisioni non siano pienamente razionali, ma condizionate da vincoli cognitivi e culturali.
- Edgar Schein ha approfondito il legame tra cultura organizzativa e purpose aziendale, evidenziando come il purpose debba essere interiorizzato e condiviso da tutti i membri dell’organizzazione per essere efficace.
- Karl Weick ha introdotto il concetto di sensemaking, che enfatizza il processo interpretativo e comunicativo attraverso cui le organizzazioni definiscono e ridefiniscono continuamente il loro purpose.
- Mary Douglas e Charles Perrow hanno discusso i rischi connessi alla perdita di chiarezza sul purpose aziendale, che può portare a incidenti organizzativi e crisi di legittimità.
- Amitai Etzioni, con il suo approccio socio-economico, ha proposto una visione del purpose aziendale fortemente legata alla responsabilità sociale delle organizzazioni, anticipando tematiche moderne come la sostenibilità e l’etica aziendale.
✏️ Purpose in sintesi Il purpose aziendale è la “ragion d’essere” di un’organizzazione. Non è solo fare profitti, ma avere un impatto positivo e coerente con i propri valori. Deve essere chiaro, condiviso e orientare ogni decisione strategica.
Purpose aziendale nella contemporaneità
Nel panorama contemporaneo, un nome noto è quello di Simon Sinek, che con il suo “Golden Circle” ha reso celebre la domanda “Perché?” (“Why?”) come centro fondamentale di ogni organizzazione di successo. Il purpose aziendale, secondo Sinek, è l’elemento centrale che guida strategie, processi decisionali e azioni quotidiane di tutte le organizzazioni efficaci.
Applicazioni pratiche del purpose aziendale: casi e riflessioni attuali
Nelle nostre interviste realizzate con Rosario Sica, con Andrea Cirillo e Paolo Cervari e con Alessandro Donadio emergono applicazioni molto concrete di queste riflessioni teoriche.
Cos’è il purpose washing e come evitarlo
Rosario Sica sottolinea la necessità che il purpose aziendale sia autentico e vissuto quotidianamente, mettendo in guardia dal rischio di un purpose dichiarato ma non praticato (purpose washing). Il purpose deve permeare le decisioni quotidiane ed essere concretamente applicato nella cultura aziendale, come dimostra il caso emblematico di Patagonia, azienda leader nella sostenibilità.
✏️ Per evitare il rischio di purpose washing, le organizzazioni possono adottare strumenti concreti come:
|
Purpose aziendale come processo ermeneutico
Andrea Cirillo e Paolo Cervari, attraverso il concetto di logos, approfondiscono ulteriormente il ruolo filosofico-pratico del purpose aziendale. Essi sostengono che il purpose non sia un’entità statica, bensì una realtà dinamica e in costante evoluzione. Deve essere continuamente interpretato, condiviso e, se necessario, ridefinito in base ai mutamenti del contesto interno ed esterno. Questo approccio richiede una capacità riflessiva diffusa e una leadership in grado di promuovere il pensiero critico e la coerenza tra strategia e azione.
Desiderio, senso e purpose
Nel libro Eros e lavoro (FrancoAngeli), Alessandro Donadio – filosofo del lavoro, docente e consulente HR – propone una visione radicale e rigenerativa del purpose aziendale, centrata sulla forza del desiderio e sulla ricerca di senso profondo.
|
Donadio invita a superare il paradigma dello scambio (prestazione contro incentivo) per abbracciare un approccio in cui il purpose diventa un motore erotico: un’energia interiore che spinge l’individuo ad agire per ciò in cui crede, anche senza ritorni immediati.
Secondo questa prospettiva, gli HR devono assumere un nuovo ruolo: facilitatori del senso, capaci di aiutare le persone a vedere il significato anche nei gesti più quotidiani. Come nella metafora della “cattedrale” – ripresa da una storia formativa – ciò che cambia non è l’azione (impilare sassi), ma la consapevolezza dello scopo.
|
Questa visione si connette direttamente ai temi della sostenibilità, dell’innovazione responsabile e del nuovo ruolo dell’essere umano nell’epoca della tecnologia illimitata. Il purpose, in questo senso, diventa la bussola etica per orientarsi in un mondo complesso.
Il potere di difendere il purpose
Anche Luca Baiguini, docente ed esperto di people management, nel suo libro “Fate pace con il potere” (Egea), sottolinea come il purpose aziendale sia una risorsa simbolica di straordinaria potenza, capace di generare adesione, senso e significato.
Tuttavia, Baiguini avverte che il purpose va anche difeso, soprattutto nei momenti di tensione organizzativa o cambiamento. Non è sufficiente guidare attraverso la leadership simbolica: a volte, è il potere in forme più strutturate – anche coercitive o economiche – a garantire la tenuta del purpose rispetto a interessi contrastanti.
Questa prospettiva rafforza l’idea che il purpose non sia solo una dichiarazione valoriale, ma una risorsa strategica da proteggere e sostenere attivamente, anche a costo di decisioni impopolari. Il rischio, altrimenti, è quello di scivolare verso una leadership populista, che sacrifica la coerenza e la forza del cambiamento sull’altare del consenso facile.
|
Le riflessioni di Rosario Sica sono tratte dall’intervista “Il Purpose Come Motore dell’Innovazione Aziendale“, quelle di Andrea Cirillo e Paolo Cervari provengono dall’intervista “Il logos dell’organizzazione” mentre quelle di Alessandro Donadio dall’intervista “Eros e Lavoro“ |
Come sviluppare un purpose aziendale efficace?
Secondo Cirillo e Cervari, il processo di definizione e ridefinizione del purpose aziendale è fondamentalmente ermeneutico, ossia interpretativo. Non si tratta di imporre uno scopo dall’alto, ma piuttosto di far emergere dal dialogo con tutte le parti interessate (stakeholder interni ed esterni) ciò che rappresenta autenticamente l’organizzazione e la direzione futura che desidera intraprendere. Tale approccio migliora motivazione, engagement, reputazione aziendale e capacità di innovazione.
Anche nelle PMI il purpose può essere un fattore critico di successo. Aziende artigiane o familiari che legano il loro operato alla comunità locale, alla qualità sostenibile o al benessere delle persone dimostrano come il purpose non richieda grandi budget, ma coerenza e visione. Un esempio concreto è rappresentato da alcune imprese agricole locali che, pur operando con mezzi limitati, fondano la propria strategia sul rispetto della terra, dei lavoratori e della filiera corta.
Come iniziare: primi step operativi
Per le aziende che desiderano avviare un percorso di definizione del proprio purpose, è utile partire da:
- Analisi interna di mission, valori e cultura aziendale;
- Coinvolgimento dei dipendenti e degli stakeholder in focus group e interviste;
- Mappatura delle aspettative sociali e ambientali emergenti;
- Sviluppo di un purpose statement autentico, seguito da azioni concrete che ne riflettano i principi.
Sfide globali: purpose e nuove tecnologie
Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, la digitalizzazione spinta e le sfide ambientali, il purpose aziendale è chiamato a evolversi. Le organizzazioni dovranno sapersi interrogare non solo sul perché esistono, ma anche su come vogliono contribuire in modo responsabile al futuro collettivo.
L’integrazione dell’AI, ad esempio, può sollevare questioni etiche e organizzative complesse: automatizzazione dei processi, ridefinizione delle competenze, impatto sui lavoratori. In questo contesto, avere un purpose chiaro può aiutare a guidare le scelte tecnologiche in modo coerente con i valori aziendali.
Allo stesso modo, i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) rappresentano oggi un riferimento chiave per valutare la sostenibilità delle organizzazioni. Integrare il purpose con tali standard significa non solo adottare comportamenti etici, ma anche rendere trasparente l’impegno verso la comunità, l’ambiente e i diritti umani.
Purpose dinamico e adattabilità al contesto
La natura ermeneutica del purpose implica che esso debba essere periodicamente rivisitato, alla luce dei cambiamenti socio-economici, culturali e normativi. Le aziende che riescono a farlo sono quelle capaci di trasformare il purpose in una vera e propria bussola strategica. Ad esempio, durante la pandemia molte realtà hanno ridefinito il loro purpose per includere il benessere psicosociale dei dipendenti o il supporto diretto alle comunità locali.
Riflessioni per il futuro
Ripercorrendo le tappe storiche e teoriche che hanno formato il concetto di purpose aziendale, risulta evidente quanto esso sia cruciale per le organizzazioni moderne, non solo in termini di branding o comunicazione esterna, ma come elemento centrale di coerenza interna, motivazione del personale e responsabilità sociale.
In un mondo sempre più complesso, il purpose aziendale non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Ogni organizzazione, per avere successo duraturo, deve costantemente interrogarsi sul proprio “perché” e aggiornare in modo responsabile il proprio scopo, integrando etica, innovazione e sostenibilità.
***
RisorseUmane-HR.it
Un progetto dedicato a chi si occupa di Risorse Umane
RisorseUmane-HR.it è un progetto dedicato a chi opera nel settore delle Risorse Umane. Divulga contenuti informativi che gli pervengono dagli stessi visitatori e offre servizi online che favoriscono lo scambio di conoscenze e la creazione di relazioni. Con oltre 50.000 pagine visualizzate ogni mese, RisorseUmane-HR.it è ad oggi uno dei portali di settore più visitati in Italia.
Un punto d’incontro esclusivo per Responsabili del Personale, Formatori, Consulenti, Persone che operano nel settore delle Risorse Umane e che sanno che per crescere è necessario uno scambio di informazioni.
Risorse aggiuntive
Potrebbero interessarti anche questi articolo:
- Purpose e spirito di comunità: possono guidare lo sviluppo professionale? | Nicolò Sambugaro
- Purpose Aziendale: bussola strategica per innovazione e impegno
- Organizzazioni rigenerative: il nuovo volto della sostenibilità
- Toxic Positivity nella cultura aziendale: quando “siamo una famiglia” diventa un incubo
- Innovazione aziendale: da opportunità a necessità
- Cultura, benessere e tecnologia in azienda: quali possibili trend per il 2025? | Nicolò Sambugaro
- Manager in crisi di fronte al cambiamento
Fonti e note:
Le riflessioni di Rosario Sica sono tratte dall’intervista “Il Purpose Come Motore dell’Innovazione Aziendale“, quelle di Andrea Cirillo e Paolo Cervari provengono dall’intervista “Il logos dell’organizzazione” mentre quelle di Alessandro Donadio dall’intervista “Eros e Lavoro“
James March e Herbert Simon – Opera chiave: Organizations (1958) Ed. italiana:
Contributo: Hanno analizzato i limiti della razionalità nelle decisioni organizzative (bounded rationality), aprendo la strada alla comprensione delle organizzazioni come sistemi complessi con valori e routine consolidate, non solo strutture tecniche.
Edgar Schein – Opera chiave: Organizational Culture and Leadership (1985) Ed. italiana:
Contributo: È uno dei massimi esperti di cultura organizzativa. Schein definisce la cultura come l’insieme dei presupposti condivisi che guidano il comportamento all’interno di un’organizzazione. Ha dato sistematicità al modo in cui il purpose si incarna nei comportamenti e nei simboli aziendali.
Karl Weick – Opera chiave: Sensemaking in Organizations (1995) Ed. italiana: “Senso e significato nell’organizzazione. Alla ricerca delle ambiguità e delle contraddizioni nei processi organizzativi”, Raffaello Cortina, 1997
Contributo: Weick introduce il concetto di sensemaking per spiegare come le organizzazioni costruiscano il significato delle proprie azioni. La sua visione rafforza l’idea che il purpose non sia qualcosa di statico, ma un processo continuo di attribuzione di senso.
Mary Douglas – Opera chiave: How Institutions Think (1986) Ed Italiana “
Contributo: Anche se più nota come antropologa, ha influenzato la sociologia organizzativa. Ha mostrato come le istituzioni “pensano” e agiscono secondo logiche valoriali, ribadendo che le organizzazioni sono portatrici di significati, non solo strumenti.
Charles Perrow – Opera chiave: Complex Organizations (1972)
Contributo: Ha descritto le organizzazioni come entità dove il potere e i valori influenzano la struttura, criticando l’idea di organizzazioni neutrali e rinforzando la necessità di una consapevolezza valoriale (quindi di un purpose implicito o esplicito).
Amitai Etzioni – Opera chiave: Modern Organizations (1964)
Contributo: Ha evidenziato l’importanza dell’impegno morale e delle dimensioni etiche nelle organizzazioni, insistendo sul fatto che l’efficacia organizzativa è legata anche al consenso attorno a uno scopo condiviso.
Simon Sinek – Opera chiave: Start with Why (2011) Ed. italiana “Partire dal perché. Come tutti i grandi leader sanno ispirare collaboratori e clienti” Franco Angeli, 2017 – Divulgatore influente: riprende (in modo semplificato) molte delle intuizioni di Selznick e Schein, portando il purpose nel mainstream manageriale.
Robert Kegan e Lisa Lahey (An Everyone Culture) – Psicologia organizzativa evolutiva: promuovono il concetto di organizzazioni deliberately developmental, dove il purpose guida non solo le performance, ma anche la crescita personale dei dipendenti.
Sintesi dell’articolo:
Purpose aziendale: radici sociologiche e applicazioni contemporanee
L’articolo approfondisce il concetto di purpose aziendale come fondamento dell’identità organizzativa, sottolineandone le radici sociologiche e l’evoluzione nel tempo. Viene evidenziato il contributo di studiosi come Philip Selznick, Herbert Simon, James March, Edgar Schein, Karl Weick e altri, che hanno messo in luce come il purpose sia molto più di uno slogan: è la ragion d’essere profonda dell’organizzazione, da cui dipendono coerenza strategica, cultura interna e legittimità esterna.
La parte contemporanea dell’articolo include l’analisi del “Golden Circle” di Simon Sinek, la critica al purpose washing (quando lo scopo dichiarato non si riflette nelle pratiche concrete) e le riflessioni filosofico-pratiche di Cirillo e Cervari sul purpose come processo ermeneutico. Viene poi illustrato come anche le PMI possano trarre valore da un purpose autentico, e si propongono azioni pratiche per svilupparlo e mantenerlo rilevante nel tempo, soprattutto in relazione a sfide come AI, ESG e trasformazioni culturali.
Quiz a risposta breve
Dopo aver letto l’articolo, prova a rispondere a questa domande:
-
Chi è considerato il padre fondatore del concetto di purpose aziendale? Philip Selznick
-
Che cos’è il “purpose washing”? La pratica di dichiarare uno scopo aziendale senza tradurlo in azioni concrete.
-
Quale sociologo ha legato il purpose alla cultura organizzativa? Edgar Schein
-
Cosa propone il modello del “Golden Circle” di Simon Sinek? Mettere al centro delle strategie aziendali il “Perché” (Why).
-
Come viene definito il purpose secondo Cirillo e Cervari? Come un processo ermeneutico, da interpretare e aggiornare nel tempo.
-
Perché anche le PMI possono beneficiare di un purpose chiaro?
Perché migliora coerenza, reputazione e impatto sociale, anche con risorse limitate.
Glossario
-
Purpose aziendale: Scopo profondo e identitario di un’organizzazione, che va oltre il profitto economico.
-
Dimensione istituzionale: Secondo Selznick, l’aspetto dell’organizzazione legato ai valori, alla missione e al ruolo sociale.
-
Razionalità limitata: Concetto di Simon e March: le decisioni aziendali sono influenzate da limiti cognitivi e culturali.
-
Cultura organizzativa: Insieme di valori, norme e comportamenti condivisi che caratterizzano la vita interna di un’organizzazione.
-
Sensemaking: Processo con cui le persone e le organizzazioni danno senso a ciò che accade, ridefinendo il purpose nel tempo (Weick).
-
Purpose washing: Dichiarare uno scopo etico o valoriale senza reali azioni coerenti, compromettendo la credibilità.
-
Logos organizzativo: Concetto filosofico usato da Cervari e Cirillo per indicare la logica profonda che guida l’organizzazione.
-
Processo ermeneutico: Approccio interpretativo che implica il continuo riesame del significato del purpose alla luce dei cambiamenti.
-
ESG: Criteri ambientali, sociali e di governance utilizzati per valutare la sostenibilità e l’impatto etico delle imprese.
-
Stakeholder engagement: Coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse nel processo di definizione e attuazione del purpose.